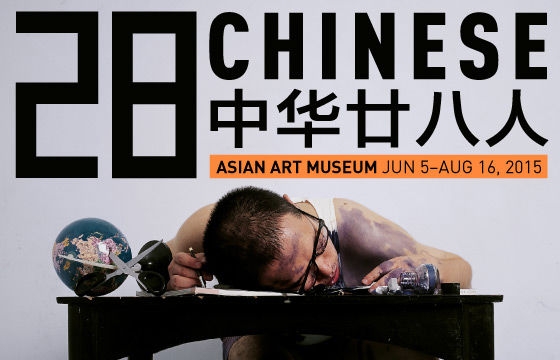La moglie di Douglas Tompkins (un imprenditore tessile, ambientalista, escursionista, regista, agricoltore, filantropo americano), giorni fa, a pochi anni dalla morte del marito (2015), ha effettuato «la più grande donazione di terra mai fatta da un privato a uno Stato», il Cile - e si appresta, altresì, a fare una donazione analoga all'Argentina -, con il vincolo che siano creati dei parchi nazionali in cui gli stati s'impegnano a preservarne la biodiversità.
Brava. E bravo il marito. E, naturalmente, giù lodi, peana, osanna per una vita spesa all'insegna di un nobile fine: la salvaguardia della natura dai disastri ambientali provocati dall'uomo. Quali uomini? Fuori i nomi, i cognomi, i conti e banca e le azioni.
Ma a parte ciò: oltre a me, c'è qualcuno che si chiede come sia possibile (tollerabile) che un "privato", una persona sola abbia potuto e possa, forte di un ingente quantitativo di quattrini, riuscire a comprare uno sterminato numero di ettari di terra del pianeta? Direte: Tompkins ha fatto i soldi legittimamente; come i Benetton, era una magliettaio anche lui, poi ha ceduto le (azioni delle) aziende e, anziché comprarsi le Autostrade, con la liquidazione ha deciso di acquistare terreni per un nobile fine che neanche un dio.
Neanche un dio, appunto.
- Eh, ma ha fatto i soldi onestamente, mica con il narcotraffico o la vendita illegale di armi.
Ma io non discuto l'onestà, la regolarità, la bravura dell'individuo. Discuto la dismisura e conseguente diseguaglianza che regolano i rapporti di proprietà all'interno di una società di classe. La finitezza umana, singola, individuale non potrebbe, da sola, essere bastante per porre un limite oggettivo che la società intera (almeno quella democratica: escludiamo le monarchie assolute e le dittature, per esempio) pone al consumo e al possesso di risorse di un pianeta finito? Giacché non esiste alcun merito, alcuna eccezionalità imprenditoriale o di altro genere che renda umanamente accettabile il fatto che qualcuno possegga sconfinati appezzamenti di suolo (e forse sottosuolo). Eppure il diritto (borghese) garantisce e tutela il diritto di proprietà fondiaria senza limiti.
Occorre però fare attenzione: non sta nell'espropriazione tout court il riscatto del bene comune, per favorire la collettività ai danni del singolo possidente; bensì nello scardinare un meccanismo economico e produttivo che determina tale smisurato squilibrio di appropriazione del valore.
La produzione sociale è frenata, inceppata dai «rapporti di proprietà».
C'è un simpatico account Twitter chiamato Has Jeff Bezos Decided To End World Hunger?
che rende bene l'idea dell'immensità della ricchezza concentrata su un solo individuo:
«Jeff Bezos has a net worth of $165bn. The UN says it would cost $30bn to end world hunger per year. So, has Jeff Bezos decided to end world hunger today?»
Ma ripeto: non si tratta di assaltare la diligenza Bezos, ma semplicemente di iniziare a rimettere in circolo alcuni ragionamenti che, sebbene siano stati formulati più di centosettant'anni fa, sono ancora gli unici in grado di fare il punto reale della situazione:
«A un certo grado dello sviluppo di quei mezzi di produzione e di scambio, le condizioni nelle quali la società feudale produceva e scambiava, l'organizzazione feudale dell'agricoltura e della manifattura, in una parola i rapporti feudali della proprietà, non corrisposero più alle forze produttive ormai sviluppate. Essi inceppavano la produzione invece di promuoverla. Si trasformarono in altrettante catene. Dovevano essere spezzate e furono spezzate.Ad esse subentrò la libera concorrenza con la confacente costituzione sociale e politica, con il dominio economico e politico della classe dei borghesi.
Sotto i nostri occhi si svolge un moto analogo. I rapporti borghesi di produzione e di scambio, i rapporti borghesi di proprietà, la società borghese moderna che ha creato per incanto mezzi di produzione e di scambio così potenti, rassomiglia al mago che non riesce più a dominare le potenze degli inferi da lui evocate. Sono decenni ormai che la storia dell'industria e del commercio è soltanto storia della rivolta delle forze produttive moderne contro i rapporti moderni della produzione, cioè contro i rapporti di proprietà che costituiscono le condizioni di esistenza della borghesia e del suo dominio.Basti ricordare le crisi commerciali che col loro periodico ritorno mettono in forse sempre più minacciosamente l'esistenza di tutta la società borghese.
Nelle crisi commerciali viene regolarmente distrutta non solo una parte dei prodotti ottenuti, ma addirittura gran parte delle forze produttive già create. Nelle crisi scoppia una epidemia sociale che in tutte le epoche precedenti sarebbe apparsa un assurdo: l'epidemia della sovraproduzione. La società si trova all'improvviso ricondotta a uno stato di momentanea barbarie; sembra che una carestia, una guerra generale di sterminio le abbiano tagliato tutti i mezzi di sussistenza; l'industria, il commercio sembrano distrutti. E perché? Perché la società possiede troppa civiltà, troppi mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive che sono a sua disposizione non servono più a promuovere la civiltà borghese e i rapporti borghesi di proprietà; anzi, sono divenute troppo potenti per quei rapporti e ne vengono ostacolate, e appena superano questo ostacolo mettono in disordine tutta la società borghese, mettono in pericolo l'esistenza della proprietà borghese. I rapporti borghesi sono divenuti troppo angusti per poter contenere la ricchezza da essi stessi prodotta. - Con quale mezzo la borghesia supera le crisi? Da un lato, con la distruzione coatta di una massa di forze produttive; dall'altro, con la conquista di nuovi mercati e con lo sfruttamento più intenso dei vecchi. Dunque, con quali mezzi? Mediante la preparazione di crisi più generali e più violente e la diminuzione dei mezzi per prevenire le crisi stesse.
A questo momento le armi che son servite alla borghesia per atterrare il feudalesimo si rivolgono contro la borghesia stessa.
Ma la borghesia non ha soltanto fabbricato le armi che la porteranno alla morte; ha anche generato gli uomini che impugneranno quelle armi: gli operai moderni, i proletari.»
L'unica riserva è sulla frase finale: gli uomini che impugneranno quelle armi contro il capitalismo, non in una nazione ma nell'intero pianeta, non sono stati ancora generati. Va dato atto alla borghesia di aver impedito di far nascere i suoi becchini. Come ci è riuscita? Come ci sta riuscendo? La butto là: panem et circenses.