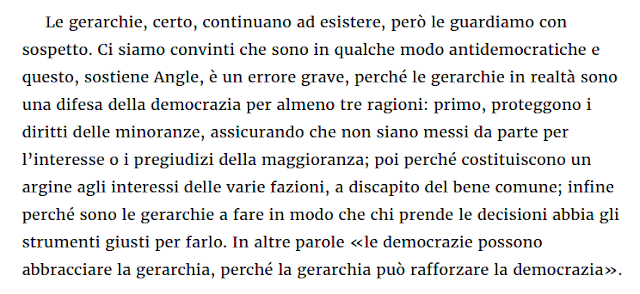O, when degree is shaked,
Which is the ladder to all high designs,
Then enterprise is sick!
In un articolo scritto
qui, si parla di un saggio (breve) scritto
qua, dove si sostengono tesi a favore della
gerarchia.
Bene, aldilà del sommo discorso che l'Ulisse shakespeariano rivolge ad Agamennone e alle truppe greche in stato d'assedio a Troia - discorso che ribadisce l'importanza del degree (grado, gerarchia) nell'ordine naturale delle cose, anche e soprattutto per contenere il caos dell'indifferenziazione e della violenza mimetica che conseguono in assenza di un ordine gerarchico («Tutto si risolve in potere: il potere in volere, il volere in appetito: e l'appetito, lupo universale, assecondato da due parti dal volere e dal potere, vorrà farsi una preda dell'universo, e alla fine divorerà se stesso» id. traduzione di Cesare Vico Lodovici, Einaudi, 1965) -, vorrei soffermarmi su alcune considerazioni estratte dal suddetto articolo, queste:
È evidente che per molte attività umane la gerarchia, il degree, è indispensabile: non si diventa medici per acclamazione, idraulici qualificati per raccomandazione, esperti informatici per sorteggio.
Nondimeno, aldilà delle abilità dei vari quadri funzionali della macchina statale (il ragioniere, il funzionario, l'ambasciatore, il portaborse, il generale, il dirigente di vario tipo), nelle democrazie l'ordine gerarchico è stabilito democraticamente mediante elezioni. Purtuttavia, è un dato di fatto che i politici, pur bravi che siano, soprattutto per salvaguardare gli interessi nazionali, in molti casi riuscendovi (in Italia meno che altrove), essi non rientrano nella categoria gerarchica di selezione del personale migliore in ordine alle sue capacità.
Allora in che senso «la gerarchia può rafforzare la democrazia»?
In un senso solo: nel guidare lo Stato di Eccezione (dell'ordine democratico). Esempio a bomba: è stato o non è stato in base a un ordine gerarchico, del Comandante in Capo (certamente su pressione e suggerimento degli alti grado dello Stato Maggiore dell'Esercito), che gli Stati Uniti d'America hanno sparato un centinaio di Tomahawk sulla Siria? E questo ordine ha rafforzato la democrazia?
No.
«Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione», sentenziava Carl Schmitt, teologo politico d'impronta nazistella. E, appunto, l'appetito gerarchico in campo politico sembra alluda a una autentica fame di autoritarismo, di aggiustapopoli con la mazza e lo scalpello perché... già, perché?
Perché in quest'epoca del tardocapitalismo avanzato il meccanismo della valorizzazione del capitale (che tutto informa e sorregge, comprese le gerarchie) si è inceppato, meccanismo che, per circostanze storiche oramai irripetibili, ha funzionato (a sbalzi) dal dopoguerra fino alla caduta del Muro di Berlino (ma anche meno), dando l'impressione di essere l'unico sistema di riproduzione economica e sociale possibile per l'umanità. Adesso che, invece, da decenni oramai, questo sistema rimasto l'unico sulla piazza cozza contro i propri limiti (invalicabili), pastori e gregge sentono nuovamente il desiderio di ordine e disciplina, di guida sicura nei momenti incerti della crisi.
Tutta gente che ha bisogno di manico, dato che lo stato di eccezione è diventato la norma nelle democrazie liberali.
«il vero nocciolo della democrazia moderna è la dittatura e la vera essenza della cittadinanza dello Stato moderno consiste, in ultima istanza, in un rapporto di potere. Il guaio è che Schmitt sottolinea certo questa sgradevole verità, ma non allo scopo di formulare una critica emancipatoria della cittadinanza giuridica e della sua forma sociale (capitalistica); al contrario egli si assoggetta alla decisione autoritaria, al puro e semplice potere decisionale come fondamento ultimo di tutta la sovranità moderna, anche e soprattutto di quella democratica. Il teorico dello stato di eccezione è, simultaneamente, il cantore dello stato di eccezione e il rappresentante intellettuale del potere autoritario come posizione ontologica.
Per Schmitt lo stato di eccezione e, con esso, il nucleo di violenza autoritaria della democrazia, rappresenta l’autentica esistenza positiva della società come comunità di lotta esistenziale della nazione mistificata nella contesa cruenta tra le nazioni. Egli avversa la democrazia liberale e lo stato di diritto come una specie di stadio di debolezza della comunità di destino nazionale, in grado di oscurare la dimensione esistenziale del politico.»
Ecco fino a che punto la gerarchia può rafforzare la democrazia. Fino alla lotta stessa delle democrazie le une contro le altre (e ci sarà sempre uno meno democratico di te da tirargli in testa bombe democratiche).
Per il resto, per chi è interessato alla questione sulla
gerarchia e lo
stato di eccezione, rimando alla lettura del IX capitolo del libro di Robert Kurz,
Weltordnungskrieg, Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung, Horlemann Verlag, Bad Honnef 2003, tradotto da Samuele Cerea. Prima parte. Seconda parte.
Godi popolo.